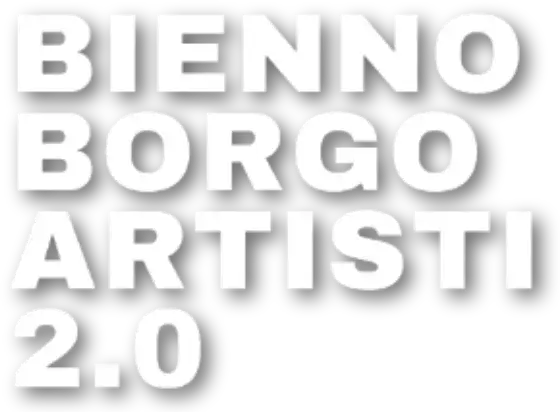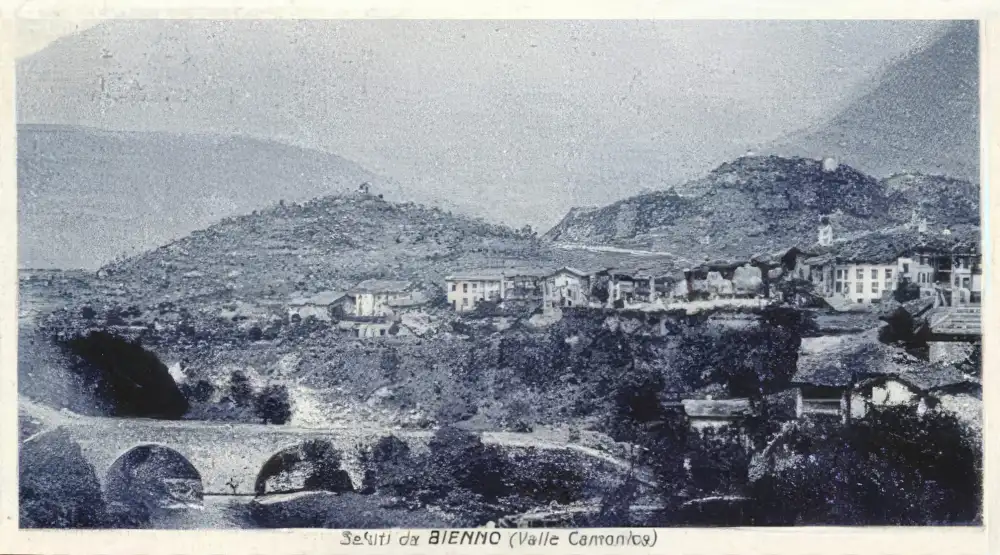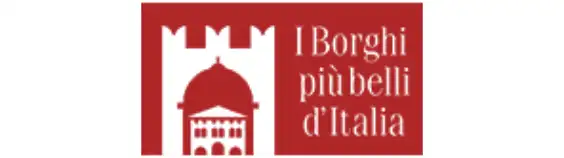Età moderna: tra arte, fede e disastri.
Il XVI secolo per Bienno è un'epoca di grande fermento, in cui si gettano le basi della prosperità dei secoli futuri. È un periodo caratterizzato da una forte continuità con la tradizione siderurgica medievale, ma anche da importantissime novità artistiche e religiose.
Consolidamento Economico sotto Venezia
All'inizio del secolo, i territori della Serenissima vivono un periodo di instabilità a causa delle guerre (come la Guerra della Lega di Cambrai). Questo si traduce in una forte domanda di ferro e armi, che spinge al massimo l'attività dei magli biennesi. Superate le turbolenze, il resto del secolo vede consolidarsi il potere economico delle famiglie locali che controllano la filiera del ferro, accumulando i capitali che nel Seicento verranno investiti nella costruzione dei grandi palazzi barocchi.
L'Eco del Rinascimento Bresciano: Romanino e Moretto
Artisticamente, il '500 è il secolo più importante per Bienno. Pur non essendoci prove dirette della loro presenza in paese, l'influenza dei due massimi maestri del Rinascimento bresciano, Gerolamo Romanino e Alessandro Bonvicino detto "il Moretto", è fortissima e visibile.
Chiesa di Santa Maria Annunciata
È il gioiello artistico del Cinquecento biennese. Al suo interno si trova un grandioso ciclo di affreschi di questo periodo, che narra le storie della Vergine Maria. Sebbene l'autore sia incerto, lo stile (l'uso del colore, la composizione delle scene, l'espressività dei volti) è chiaramente debitore della lezione di Romanino. Questi affreschi rappresentano uno degli esempi più importanti di pittura rinascimentale in tutta la Val Camonica.
La Controriforma e la sua Influenza
La seconda metà del secolo è dominata dal Concilio di Trento (1545-1563) e dall'avvio della Controriforma cattolica. L'arte diventa un potente strumento per riaffermare i dogmi della fede. I cicli di affreschi come quello di Santa Maria non avevano solo una funzione decorativa, ma soprattutto didattica ed educativa per una popolazione in gran parte analfabeta.
Architettura e Vita Sociale
Le dimore storiche di origine medievale, come Casa Panteghini o Casa Avanzi, continuano ad essere il centro della vita delle famiglie più influenti. In questo secolo vengono probabilmente abbellite e modificate secondo il gusto rinascimentale, anche se le grandi trasformazioni architettoniche avverranno nel secolo successivo. È il periodo in cui si definisce la struttura sociale che vedrà per i successivi 200 anni una borghesia di "mastri" (maestri artigiani del ferro) guidare la comunità.


Il Seicento: l'Oro Nero e lo Splendore Barocco
Il Cinquecento aveva gettato le basi; il Seicento ne raccolse i frutti, trasformando Bienno nel suo periodo di massimo splendore economico e artistico. La ricchezza accumulata con la produzione siderurgica, ormai all'apice, si riversò nell'aspetto stesso del borgo. Le grandi famiglie borghesi, come i Simoni e i Francesconi, divennero potenti committenti e manifestarono il loro prestigio edificando i loro sontuosi palazzi.
È in questo secolo che il volto di Bienno cambia: i cortili si aprono in eleganti loggiati, le facciate si impreziosiscono e gli interni si arricchiscono di decorazioni. Lo stile che domina è il Barocco, opulento e scenografico, che trova la sua massima espressione nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, ampiamente ristrutturata per riflettere la prosperità e la devozione della comunità.
La vita del borgo era un contrasto vibrante: da un lato il ritmo assordante e incessante dei magli mossi dalla forza del torrente Grigna, cuore pulsante di un'economia che esportava attrezzi e manufatti in tutta la Repubblica di Venezia; dall'altro, la ricerca della bellezza e della fede, finanziata proprio da quel "nero oro" forgiato nelle fucine.
Una prosperità drammaticamente interrotta solo dalla terribile peste del 1630, che decimò la popolazione ma dalla quale la tenace comunità biennese seppe ripartire.


Il Settecento: l'Ultima Stagione Veneta e la Fine di un'Era
Il XVIII secolo si apre sulla scia della prosperità del Seicento. L'attività del ferro, seppur insidiata da nuove tecnologie e centri produttivi, continua a sostenere l'economia del paese. L'arte e l'architettura proseguono il percorso tracciato, portando a compimento i cantieri barocchi e arricchendo ulteriormente il patrimonio artistico e civile del borgo.
È una stagione di consolidata ricchezza, l'ultimo atto di un lungo periodo di stabilità. Ma l'equilibrio secolare si sta per spezzare. Sul finire del secolo, venti di cambiamento epocale soffiano sull'Europa. Il colpo di grazia arriva nel 1797 con il Trattato di Campoformio: Napoleone Bonaparte pone fine alla millenaria storia della Repubblica di Venezia.
Per Bienno, come per tutta la valle, la caduta della Serenissima non è solo un cambio di governo. È la fine di un'epoca, la chiusura di un orizzonte politico ed economico durato quasi quattrocento anni.
Si conclude così quel lungo e prospero capitolo della storia di Bienno, lasciando in eredità un patrimonio di arte, architettura e saperi che ancora oggi ne definisce l'identità unica.